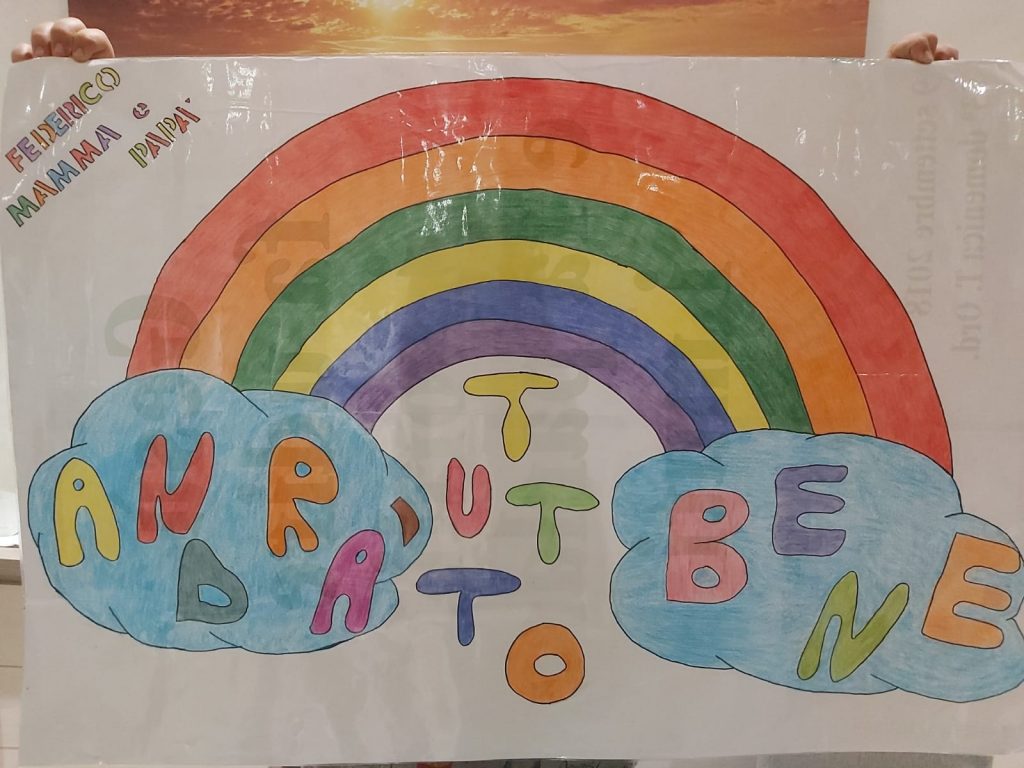L’arcobaleno è scolorito ma la scritta è ancora ben visibile. Quell’”andrà tutto bene” attaccato dai primi di marzo alla porta d’ingresso del condominio incrocia ormai solo sguardi indifferenti e disillusi. Pur in tempo di vacanza, la stanchezza è palpabile, attenuata solo dal termometro che attesta il cedimento del fronte caldo africano. Non sta andando affatto tutto bene, anche se in un prato cittadino ci si lascia lusingare da un normale (in altri tempi) assembramento giovanile e su di un manto erboso alpino qualcuno spara note irriverenti proprio dove correva un fronte di guerra.
Nelle chiese, ad agosto, si fatica anche a trovare un volontario che orienti a rispettare le regole di base: sanificazione, mascherina, distanziamento. Quest’ultimo non pare peraltro un problema: in tanti ancora in chiesa non hanno rimesso piede, per timore del contagio o anche solo per la difficoltà ad accettare limitazioni che rendono problematica la partecipazione alla liturgia, compromettendo la percezione di un legame comunitario. Già, la comunità. L’estate sarà ancora un periodo di tolleranza in cui accettare un rodaggio imprevisto, ma a settembre – salvi i sacrosanti vincoli sanitari – in qualche modo si dovrà pur rimettere in moto una macchina comunitaria degna di tale patente.
Ma anche se la ripresa della vita comunitaria non andasse molto lontano dall’azzoppata pratica liturgica consentita, servirà comunque uno scatto in avanti, la presa di coscienza che non basta pretendere la riapertura delle chiese e affidarsi alla potenza del Mistero, ma serve riempirle di afflato, farle respirare di umanità, di vita, di storie personali, di cadute e di redenzioni. A maggior ragione in uno stato di crisi perdurante e per molti aspetti devastante come quello in cui siamo immersi da quasi sei mesi. Riconsegniamo dunque al momento celebrativo il connotato della festa autentica e non solo quella teorizzata nei manuali teologici. È la sfida di sempre, d’accordo. Ma forse è giunta l’ora in cui considerarla improcrastinabile. Perché è questo il momento in cui ripensarsi per un diverso streaming ecclesiale, come ha richiamato il vescovo Lauro nella sua Lettera in tempo di Covid. Non adagiamoci a una Parola di Dio sbiascicata sottovoce, rivitalizziamo gli sguardi e lasciamo ridere gli occhi dietro il volto velato. Non che sia facile stare a un ambone e trasferire contenuti di senso a una platea surreale. Ma non è nemmeno facile stare dall’altra parte subendo talora una retorica cantilenante e frasi fatte nelle quali non percepisci emozioni autentiche. Certo, se la liturgia celebra la vita, è lì che dovremmo agire per purificarne la fonte.
Verrebbe da dire: su la mascherina, ma giù la maschera! L’isolamento forzato ha accentuato l’emergenza antropologica. L’ossigeno di cui abbiamo bisogno è recuperare verità dentro noi stessi (ce lo ricorderebbe in modo mirabile Dostoewskij) e nei rapporti interpersonali, spesso mistificati dalla convenienza del momento, che diventa cinico opportunismo. Tutti ne siamo poco o tanto attori e vittime. Perché, per dirla con De Gregori, la storia siamo noi, e che nessuno si senta escluso. Siamo noi una comunità irrigidita e disorientata. Siamo noi una Chiesa affaticata. Siamo noi le nostre fragili famiglie. Ma siamo sempre noi quelli in cui Qualcuno continua a credere. Sarà faticoso, ma andrà tutto bene.